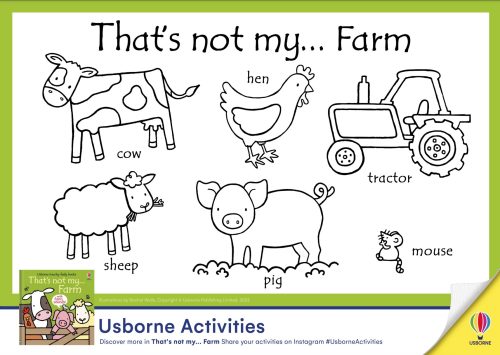In una lettera al nonno, la forza dei legami familiari
 Una lettera toccante scritta da una nostra lettrice, Frida Uruci, al nonno, a cui era molto legata e che ha contribuito in modo profondo alla sua formazione e alla costruzione della sua identità. Una lettera che ognuno di noi vorrebbe ricevere, e che è la testimonianza migliore di come una parte di noi continui a vivere nei nostri nipoti.
Una lettera toccante scritta da una nostra lettrice, Frida Uruci, al nonno, a cui era molto legata e che ha contribuito in modo profondo alla sua formazione e alla costruzione della sua identità. Una lettera che ognuno di noi vorrebbe ricevere, e che è la testimonianza migliore di come una parte di noi continui a vivere nei nostri nipoti.
La nostra vita inizia quando iniziamo ad avere memoria.
I miei primi ricordi sanno di campi di grano e fichi, hanno il sapore della rakia (nome della grappa in vari paesi dei Balcani) e camminano a piedi nudi sporchi di fango.
Avevo forse 3 anni, ero una bambina dai capelli biondi e fini, con una terribile frangia che metteva bene in evidenza il viso tondo. Occhi piccoli a mandorla tanto da chiamarmi “cinese” e labbra rosse e grosse che parlavano solo se interpellate.
Camminavo dietro mio nonno.
Raccogliendo fiori di elicriso, cercando di capire le parole di quelle storie antiche che cantavano gli uomini del popolo.
Il nonno zappava e cantava, aveva la voce dolce, bassa e calda. Era un uomo forte e coraggioso, sfidava il caldo spietato di quel paesino nel cuore del Mediterraneo senza mai ammalarsi, a petto nudo ricoperto di sudore e orgoglio.
Nonno era un residuo della seconda guerra mondiale che dalle sue parti passò senza stravolgere molto uomini e terre. Era un contadino, un uomo dalle mani grandi e callose. Indossava sempre la camicia e quando andava in città si premiava lustrando le sue vecchie scarpe.
Per lui la terra non era solo sopravvivenza o vita, ma il significato da dare ad essa. Sulla terra c’erano le risposte di tutte le domande.
Casa sua era casa mia, nonno la casa l’aveva costruita lui, le pietre, le finestre, i fichi nel giardino, la stalla degli animali, il pozzo dell’acqua.
Io sono nata in quel paesino dove il sole è presente almeno 300 giorni l’anno, e i primi anni di vita li ho vissuti in quella casa di due piani di pietre e canzoni popolari intorno al fuoco seduta sulle ginocchia del nonno. Sono cresciuta bevendo il latte anche dalla tetta della mucca e mangiando uova crude appena fatte. Sedevamo sotto l’ombra di quel fico settembrino io e il nonno. Mi allungava il bicchiere di rakia, Io assaggiavo e mi venivano le lacrime agli occhi. Lui rideva e iniziava a cantare quelle canzoni di amori sofferti e guerre tra popoli, il significato delle quali l’ho capito molto anni dopo.
Mi stringeva forte e mi diceva “tu sei una zingara, lo so, un giorno te ne andrai via lontano, ti sposerai in Australia e ti dimenticherai di me”.
Non sapevo dove si trovava l’Australia, probabilmente nemmeno lui lo sapeva, ma nei miei sogni iniziai a vedermi in cammino verso questo posto lontano, a piedi nudi, senza frangia, parlando lingue sconosciute, cantando le canzoni del nonno.
Sono passati 12 anni da questa fotografia, da questo nostro ultimo tramonto tra quelle terre da dove provengo.
Ti penso nonno e ti porto con me anche in questo mondo nuovo senza più terra, senza più dialetti perché mi servi per tradurre questa vita diversa da quella che tu mi hai fatto conoscere. Mi servi quando ho paura di perdere l’identità in questa folle giungla umana.
Ti porto sempre con me, nel cuore, quando cammino scalza, quando bevo la grappa, quando pronuncio il mio cognome, quando vedo un campo di grano.
Sei con me, ho i geni che sanno di te, del tuo sudore, della tua terra.
Sono ancora in viaggio verso la nostra Australia.
Sii fiero di me.
Frida Uruci